L’attacco di Hamas: tra violenza e disperazione

Quando Dio la promise ad Abramo (Genesi 15:13-21) era la “terra del latte e del miele”; oggi è diventata la terra del “sangue e del sudore”. Stiamo parlando della Palestina ovviamente, di quella travagliata terra del Medio Oriente, culla di antiche civiltà, ma anche sede, per secoli, di scontri, ostilità e guerre protrattesi fra alterne vicende fino ai nostri giorni.
Ne è prova del resto il conflitto fra Israele e il popolo palestinese che, rimasto irrisolto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha assunto via via toni sempre più aspri fino ad esplodere nei tragici eventi di questi giorni con l’attacco di Hamas allo Stato di Israele.
L’ “operazione al-Aqsa”, come è stata chiamata dai miliziani palestinesi con riferimento alla più grande moschea di Gerusalemme, rappresenta probabilmente l’azione più aggressiva e cruenta che sia mai stata intrapresa dai tempi dell’Olocausto contro gli ebrei. Unanime è stata pertanto la condanna da parte del mondo di questa inaspettata aggressione che, agli occhi di molti esponenti politici occidentali, è apparsa come espressione di un cieco quanto spietato terrorismo.
Tuttavia, se vogliamo giudicare l’evento al di là delle reazioni emotive che la notizia di una tragedia immancabilmente suscita, non dovremmo limitarci all’esame dell’attuale fotografia dei fatti, bensì estendere il campo di indagine a tutto l’arco di tempo in cui la questione palestinese si è svolta, dalle sue origini fino ai nostri tempi, per poi contestualizzarla, sul piano politico, nell’ambito di quella “promessa” fatta dagli inglesi al popolo ebraico con la Dichiarazione Balfour del 1917.
L’atto, così chiamato dal nome dell’allora Ministro degli Affari Esteri, prevedeva l’impegno del Governo britannico a facilitare la creazione di un “focolare nazionale” per gli ebrei in Palestina, contando a tal fine – ma anticipando gli esiti della Prima Guerra Mondiale – sull’assegnazione di quella terra da parte della Società delle Nazioni, per il tramite di un mandato di amministrazione fiduciaria. Ma, dettaglio non trascurabile ai fini di una disamina obiettiva e imperiale, “senza pregiudizio dei diritti per le altre comunità lì già presenti”.
Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, e venuto a scadere il mandato britannico sulla Palestina, l’ONU – ritenendo di dare ulteriore seguito alla decisione britannica, ma scostandosi incisivamente dalle iniziali previsioni della Dichiarazione – ha inteso dare un definitivo assetto alla questione della convivenza dei due popoli prevedendo, a termini della Risoluzione n. 181 del 1948, la creazione a loro favore di due rispettive entità statuali. Ma la iniqua spartizione dei territori, a tutto vantaggio delle pretese sioniste, per giunta in un quadro demografico profondamente alterato dai flussi migratori degli ebrei (segretamente tollerati dal Governo britannico per tutto il tempo del mandato), ha portato ad una unanime reazione di tutti i Paesi arabi dando avvio a quella serie interminabile di ostilità e guerre che altro non hanno fatto se non scavare un solco sempre più profondo di odio e di intolleranza tra le due parti.
Se questi sono i fatti incontrovertibili della Storia, ci sarebbe tuttavia un’ altro aspetto da considerare a completamento del quadro valutativo: l’atteggiamento di assoluta intransigenza tenuto da Israele nel corso dei decenni nel non pervenire a nessun accomodamento della situazione. Una posizione, questa, che troverebbe spiegazione sulla base di una rigidità negoziale fondata sulla “forza” e sulla consapevolezza delle vittorie da Tel Aviv conseguite in tutte le guerre fin dalla nascita dello Stato di Israele. Ma a pervenire ad un tale esito, non è stato indifferente – né tanto meno lo potrebbe essere oggi – l’aperto e scontato sostegno dato dagli Stati Uniti in virtù delle forti comunità sioniste lì presenti e che tanta parte hanno avuto, e hanno tutt’oggi, nel determinare le direttrici dell’imperialismo americano.
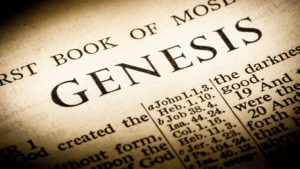 Ecco allora che la contrapposizione tra palestinesi e israeliani acquista di chiarezza e intelligibilità sia nei termini che nei contenuti, risultando il conflitto non tanto come uno scontro tra etnie e religioni – che non avrebbe senso peraltro se solo considerassimo quanto disse Dio ad Abramo a riguardo delle due stirpi che i suoi due figli Isacco e Ismaele avrebbero generato (Genesi 21.11-13) – , bensì come disputa per una terra promessa erroneamente ad entrambi i popoli in disprezzo dei più elementari principi di equità ed imparzialità.
Ecco allora che la contrapposizione tra palestinesi e israeliani acquista di chiarezza e intelligibilità sia nei termini che nei contenuti, risultando il conflitto non tanto come uno scontro tra etnie e religioni – che non avrebbe senso peraltro se solo considerassimo quanto disse Dio ad Abramo a riguardo delle due stirpi che i suoi due figli Isacco e Ismaele avrebbero generato (Genesi 21.11-13) – , bensì come disputa per una terra promessa erroneamente ad entrambi i popoli in disprezzo dei più elementari principi di equità ed imparzialità.
La violenza, dunque, con cui oggi si esprime la ribellione dei palestinesi non può liquidarsi definendola semplicemente come “terrorismo”, frutto cioè di una attitudine di un popolo alla perversione del male, ma diventa disperazione e voce di un popolo, espressione di una profonda afflizione di cui i palestinesi soffrono e che non trova rispondenza presso i Governi occidentali – inclusi gli Stati Uniti – sordi di fronte al dovere etico di realizzare una giustizia che è stata loro negata sulla base della legge del più forte.
E’ così allora che dal 1948, anno della sua nascita, si è permesso allo Stato di Israele di espandersi gradualmente oltre i confini originariamente stabiliti; è così che da quell’ anno si è accordato ad Israele il diritto di imporre ai palestinesi condizioni di vita disumane quali vediamo oggi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania); e ancora, è dal 1948 che si è consentito al Paese della Stella di Davide di erodere terre al popolo palestinese invertendo addirittura il corso della Storia!
Se, infatti, erano gli ebrei prima alla ricerca di una “terra promessa”, ora saranno i palestinesi a doversela cercare, perché cacciati da un suolo che loro apparteneva.
Certo, la violenza va censurata in tutti i modi e da qualunque parte essa provenga. Non esiste ragione per ammetterla, infatti. Ma non si deve neppure dimenticare l’atrocità degli eccidi perpetrati da Israele nel corso degli anni ai danni dei palestinesi, né, e soprattutto, l’ignavia colpevole dimostrata dai Paesi occidentali, e in particolare dagli Stati Uniti, principale alleato di Tel Aviv, nell’evitare di affrontare la questione con spirito di equità e, soprattutto, in aderenza ad un imprescindibile principio di giustizia.
Non è più questo il momento per l’uso della forza, né per minacciarla. Il potere egemonico che è stato imposto nei tempi più recenti da parte di alcune elite ai popoli e alle Nazioni, e di cui le Potenze occidentali hanno creduto, falsamente, di possedere l’esclusiva titolarità, appartiene ormai ad una concezione oscurantistica e ancora colonialistica del mondo. Ogni civiltà, e per essa ogni popolo e ogni comunità, ha diritto alla difesa, alla identità e all’auto-determinazione per il solo fatto di esistere come atto di natura. L’idea perciò di un mondo globalizzato, tecnologicamente avanzato, ma che non sconti in sè questa esigenza, non potrà mai aspirare ad un vero e genuino progresso.
Ecco allora porsi in una prospettiva come questa l’esigenza di un superamento della concezione arcaica e nichilistica della comunità internazionale; e ciò in vista di privilegiare quell’idea di mondo multipolare che, affrancato da lotte competitive, sia capace di sintonizzarsi sulla frequenza della condivisione della ricchezza, della pace e della solidarietà.
L’attacco di Hamas va, dunque, certamente biasimato per il suo portato di dolore e sofferenza; ma che dalla disperazione che esso vuole trasmettere possa l’Occidente almeno trarre la giusta ispirazione per una nuova visione con cui affrontare il dramma palestinese – come anche le tante altre crisi di identità dei popoli oggi esistenti – riconoscendo il primato dell’unica forza veramente valida ed ammissibile, ovvero quella di un rinnovato spirito di umana solidarietà.
Bruno Scapini
già Ambasciatore d’Italia















































































